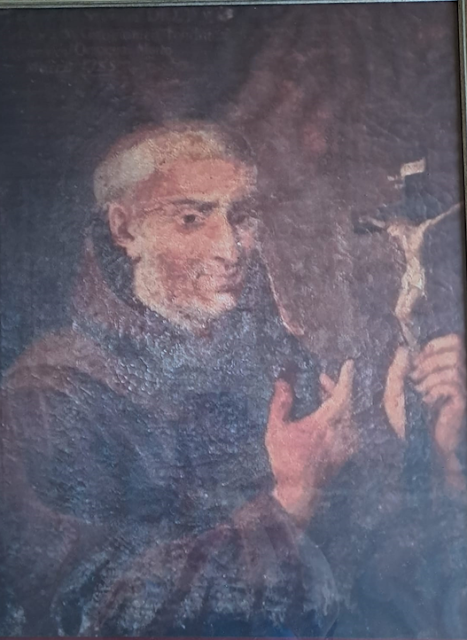12 ottobre 2025
Archivio Luigi Polacchi.
15 settembre 2025
Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano "S.Pio X" di Chieti. Brevi note storiche.
6 luglio 2025
Francescani illustri nel Convento del Ritiro della Santissima Annunziata di Orsogna: Padre Francesco da Caramanico, Padre Cristoforo da Penne, Padre Ludovico Fonzi da Orsogna.
Le glorie francescane illuminano la storia del Convento della Santissima Annunziata del Poggio in Orsogna, sin dal XV secolo, quando fu fondato da S. Giovanni di Capestrano nel 1448.
Da un dattiloscritto inedito dell’orsognese
Vincenzo Simeoni (1904-1994), appassionato di storia patria, leggiamo degli
estratti che illustrano le biografie dei personaggi più illustri.
24 maggio 2025
Detti popolari dialettali abruzzesi raccolti da Luigi Polacchi.
di Angelo Iocco
Luigi
Polacchi di Penne (1894-1988) nel corso dei suoi studi filologici sulla storia
del Risorgimento abruzzese, e negli intervalli di tempo, tra una composizione e
l’altra, tra una novella pubblicata su
L’Adriatico di Pescara e sulla rivista Tempo
nostro, si dedicò allo studio del dialetto abruzzese. Polacchi, nonostante
la sua formazione prettamente classicista, poneva lo studio della lirica
abruzzese in rapporto al dialetto, alla parlata popolare, di cui anche il
prozio e poeta Clemente De Caesaris (1810-1877) pennese, di cui Polacchi curò
l’opera omnia, inficiò alcuni suoi carmi in versi liberi endecasillabi. La
parlata abruzzese contagiò Polacchi, tanto da comporre poesie e canzonette come
Brunetta mia simpatica o Rènnele, o ancora Lu pappagalle, edite nella ristampa dell’opera omnia ORGANO vol. I
(1951, poi 1980). Mentre Polacchi si accingeva a raccogliere i detti popolari
ascoltati tra l’area pescarese e pennese, scoppiò la Seconda guerra mondiale, e
il progetto fu interrotto. Anzi, Candido Greco nel ricostruire la vita dello
scrittore, ricorda che il Polacchi, nella traversata frettolosa del torrente
Barricello, in località Torre del Duca a Penne con le casse delle carte messe
alla meno peggio a dorso d’asino, il poeta perdé molto materiale per la strada.
Tutto quel materiale che raccolse amorosamente, ascoltano i detti dialettali
dalla madre Vincenzina Di Biase. Tutto però non è andato perso, poiché nel
carteggio di Polacchi presso il Villino “Nonnina” di Pescara, grazie alla
collaborazione con la dott.ssa Angela de Sanctis, abbiamo rinvenuto delle copie
di un dattiloscritto, pieno di detti popolari.
Magari
il progetto di raccolta doveva essere più ampio, ma quel che resta tanto basta
a illustrare gli antichi detti dei nostri avi abruzzesi. Ce n’è per tutti,
dall’amore alla satira, dal lavoro alla tipica sagacia abruzzese, che tanto ci
rende caratteristici nella selva dei vari dialetti italiani.
ELENCO
PROVERBI POPOLARI DI L. POLACCHI
1) Chi nasce quatre, nen more tonne.
2) Mandrie e pecurale da le munde se n’arecàle.
3) La juvanezze è sempre allegre e nappe.
4) Ogne tratture porte a l’abiture.
5) Nu passante fannullone schiante e lasce penzulòne.
6) Panza piene nen dice male. Panza piene dai repose.
7) Pioggia juvanette li picciune sotte a lu tette.
8) Addusulète a me: facète lu bbene e perdete lu male.
9) Lu lette nnè li rose, si ‘ngi si dorme ci s’arpose.
10)
Chi te’ lu celle
‘mmane e nen le splume, je scappe sempre da la vite la furtune.
11)
Si a Rrome sème
ardùtte ognune penze a ssè e Ddij pe’ tutte.
12)
Currève anninze
gne nu sciòltavante.
13)
A la zappe e a
la traje tutte jurne nghe la paje.
14)
Casce e ricotte,
raggione a cà torte.
15)
Lu harbìne fére
distante da lu mare a la vallate.
16)
Bianche e nire
li ciaudèlle sembre tante muncacelle.
17)
Chi belle vo’
paré tutte l’usse ja da dulé!
18)
A lu cante de lu
halle fatte jurne è na la valle.
19)
Quanne cchiù
splenne lu sole, stinne bbone ssì lenzòle.
20)
A piante nu
cellette tra le fronne rise e cante va pe’ lu monne.
21)
L’amore quant’è
belle, sempre cchiù è litigarelle.
22)
A Santa Croce si
vatte la noce.
23)
Cioppe a ballà e
ciavaje a cantà.
24)
Corpe sazie:
dajje repose!
25)
Quande ‘nci sta
la hatte, lu sorge abballe.
26)
L’albere che nin
frutte, attizze.
27)
Chi je piace lu
lette lu ‘spizie l’aspette.
28)
Chi di ferre
fére, di ferre pére.
29)
Li quatrine fa j
‘acque a monte e a bballe.
30)
L’ucchie de lu
patrone ‘ngrasse lu cavalle.
31)
A Natale si
magne li caciune, a Pasque se magne li fiadune.
32)
Piagne lu morte:
è lacrime perse.
33)
L’acque chenna
piòvete ‘ncìle sta.
34)
La farine de lu
diavele ariò tutte ‘ncanìje.
35)
Chi joche a lu
lotte e spere di vince, lasse le stracce e pije li cince!
36)
Chi troppe li
tire, troppe li stucche.
37)
Sott’all’acque
ci sta la féme, sott’ a la neve ci sta lu pane.
38) Ecche lu curallare, femmene: accàttete pepe, carofene, ‘ranète fine,
rabbèerbere e chine!
39)
Abbìje ssi
faciule a’rmonne, abbiticchià ssi fronne!
40)
Donna belle a
marità, ‘n Paradise arrivète e a tre jurne maritata na ‘halline scinnicàte!
41)
Meje nu giovine
‘n camiciole che cente vicchie aricamate d’ore.
42)
Chi te’ rogne
carpe, chi te tigne gratte.
43)
Metté lu cule a
lu tommele!
44)
Lu medeche
pietose fa la piaghe cancrenose.
45)
La mannattare de
le monache nnarvinèje.
46)
Chi te’ pètre
nnin pate, chi te’ mamme nnin plagne.
47)
Ddo’ sta na
terra tra muntagne e mare, la nature divente la cchiù care.
48)
La ggente
celebrate de l’Abbruzze ‘ncontre simpatie ogne perlustre.
49)
L’ammore è nu
dolce suspire, c’ogne cchiù bella femmene ammìre.
50)
Ma lu vere
tradetore è nu sguarde de l’ammore?
51)
Chi dilitte nen
ha, de la Corte nin treme.
52)
Dumane e
pisdumàne, passa-vie ca ve’ dumane!
53)
Chi nnin te’
bona cocce, tè bbone pìte!
54)
Rénnele ca
turnate pare tutt sturdullite!
55)
Vracce a carijà,
vocche a magnà.
56)
A core stracche,
pinzìre fiacche.
57)
Chiù truve gente
gesse, chiù ‘nci pù ma’ cummatte.
58)
Quanne piagnème,
nisciune n’hà pìte!
59)
Ugne pappahalle
si pose arruffate, pronte a la battaje.
60)
Chi àveze lu
varile e se li d scole, jà ‘rmaste pe’ campà poc’anne sole.
61)
La femmene che
lu cule abballe, se puttane nen è regula falle!
62)
Se l’ommene fa’
funzionà la mente, s’artrove ogne jurne cchiù cuntente.
63)
Quande
l’amicizie t’à scurdate, cunvé cacche vote esse artruvate.
64) Matalene, Matalene, nen lassà chi te vo’ bbene, ti vo’ bbene quande Padre,
Fije e Spirte
Sante!
65) Ciampicune ciampicune arrivé nu puver’ume, le femmene a le porte jome
devé ‘mpo’ di
gnocche.
66)
La hatte che
n’arrive a lu larde, dice che è rance!
67)
Li solde de
l’avare se le magne lu sciampagnone.
68)
Maje sabbate
senza sole, maje femmene senza amore.
69)
Mandricchie e
mandricchione fa lu còmete de la patrone!
70)
Chi fa le facce
a fronte, sente ‘ngolle rossore prufunne.
71)
Maje a la Terra
me’ a carpì chi a quelle dill’itre a mète.
72)
Povere a chi
more, c’armàne cambe.
73)
Fa’ na fatija a
patte e stucche.
74)
Cent’anne e
cente mise ognune arvà a lu paese se’.
75)
Patrie, famije e
Ddie pe’ Mazzine ha fatte trie!
76)
Ddie, Patrie e
Mazzine, Patraterne une e trine!
77)
Gne nu Capudanne
arvé nu fije, tutte cose vicchie porte vie!
78)
Triste è lu
discipule che nnavanze lu mastre.
79)
La femmene è gne
lu mare: quande è calme ‘nganne!
80)
Casa quante nu
nide, terre quante ne vide.
81)
A chi nin piace
la cocche e lu vine, pozza murì dumane matine!
82)
Le Moneche di
Santaustìne: ddu cocce e nu cuscine[1].
83) Sabbatine, Sabbatine tre piducchie arrète a la schine, une saie, une cale, n’atre
fa da
Capurale!
84)
Pummadore e
pipidune l’ardicrie de li cafune.
85)
Chi te’ cente
fijje l’allòche, chi ne te une l’affòche!
86)
Casa quante nu
nide, terre quante ne vide.
87)
Ggenta triste
numunàte e viste!
88) Ame l’amiche t’ ‘nche li difetta suo’.
[1] Riferito
all’Ordine delle Monache che abitavano ai tempi di Polacchi nel convento di S.
Agostino di Penne.
20 maggio 2025
C. Greco, Clemente De Caesaris. Vita, opere e lotta per l’Unità d’Italia.
13 maggio 2025
Modesto Della Porta, a cura di Mario Palmerio.
23 aprile 2025
Sciarretta A-L, "Colonie Slave (Schiavoni) nel XV - XVI sec. nell'Abruzzo e Molise Adriatico".
25 marzo 2025
Leonzio Compassino da Penne e i pittori Giovanni e Francesco Ragazzini in Abruzzo - Pittura manierista abruzzese.
 |
| Leonzio Compassino, Martirio di Santa Rufina, chiesa di San Giovanni Battista, Castelli |
di Angelo Iocco
Da uno studio di Marco Vaccaro dal titolo Oltre la ceramica: pittura a Castelli tra XVII e XVIII secolo, 2021, Castelli. Quaderno del Museo delle ceramiche - n. 10, ci siamo interessati di questi pittori poco conosciuti, attivi tra Marche e Abruzzo. Di Leonzio Compassino da Penne, vissuto tra la seconda metà del ‘500 e la prima del ‘600, attivo almeno fino al 1620, ebbe tra i primi recensori il prof. Francesco Verlengia, che in una delle schede per la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Artistici d’Abruzzo per la provincia di Chieti, nel 1935, riportava con una cattiva lettura il nome di “Teonzio Compassino” come autore di un celebre e antico quadro nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione a San Vito Chietino. La tela è firmata, attraverso dei restauri si è meglio compresa la lettera iniziale. Tale quadro faceva parte dell’antica chiesetta di San Vito martire, che affiancava il torrione circolare con la porta di accesso all’antico paese, provenendo dalla strada grande oggi corso Matteotti.
Essa dunque affacciava sulla piazza Garibaldi, incassata tra la fortificazione del castello e altre abitazioni, come è stato studiato nel lavoro di Vito Sbrocchi La Regia Chiesa parrocchiale di San Vito, Rivista abruzzese, 1997, e andò completamente demolita poco prima del 1850, nonostante dei progetti di ammodernamento e recupero, affinché fosse costruita la nuova chiesa oltre il perimetro murario. Il quadro del Compassino illustra al centro San Vito nelle vesti di martire, con i cani al guinzaglio, simbolo del martirio, tra San Modesto di Lucania e San Crescenzo, martirizzati tutti e tre sotto Diocleziano[1].
 |
Filippo Sargiacomo, progetto di ampliamento della chiesa
madre di San Vito Chietino, Archivio storico comunale di Lanciano, Fondo
Sargiacomo. |
La raffigurazione è scenografica, abbiamo sullo sfondo un
edificio caratterizzato al centro da un monumentale arco in marmo a tutto
sesto, e accanto rispettivamente a destra e sinistra, un ordine di colonne a
capitello dorico. Il dipinto dimostra chiaramente di rimontare all’arte della
Grande Maniera di Raffaello o del Veronese (il di cui nipote Luigi Benfatto in
Abruzzo, dipinse per la chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto una tela
raffigurante Sant’Agostino), tuttavia vi sono alcune stonature poiché la
prospettica scenografia sembra quasi essere scavalcata dalla mole dei tre
personaggi illustrati.
 |
Nostra ipotesi è che altri pittori legati al Compassino o
alla scuola emiliana, potessero essere scesi nella ricca Lanciano, famosa per
le Fiere e commerci, dei quali qualcuno venne chiamato a realizzare una tela di
scarso valore stilistico, che raffigura Sant’Agostino tra Santa Rita e un
Santo, oggi presso la cappella di Santa Croce, dove si conserva un frammento
del Miracolo della Ricciarella.