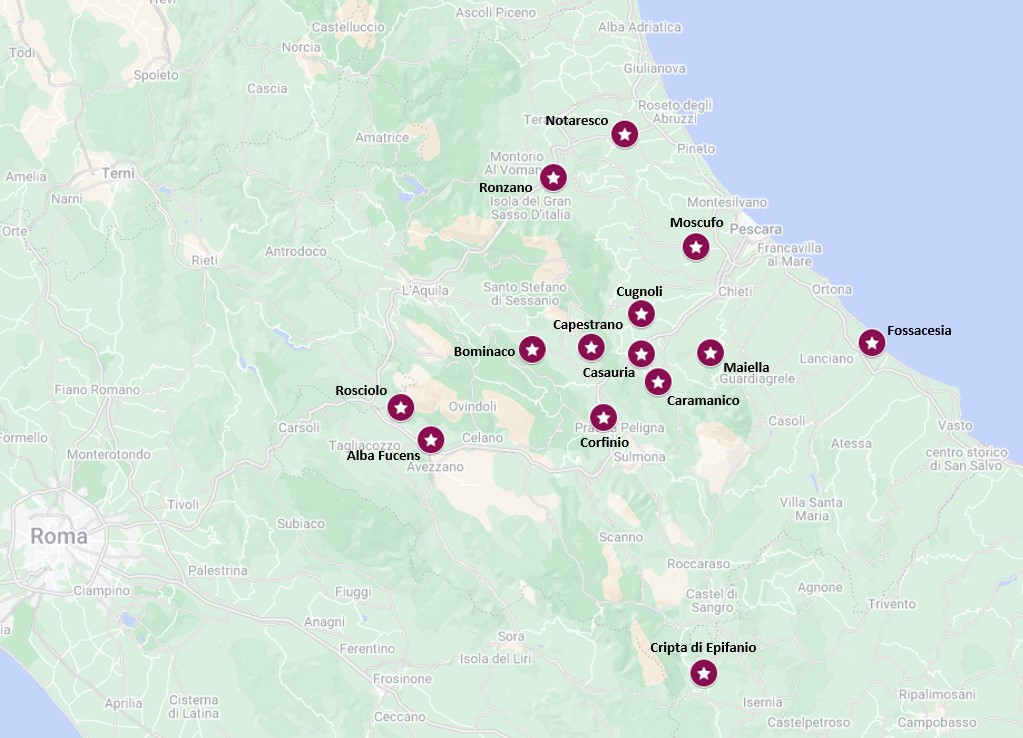|
| Giorgio Castriota Skanderbeg, busto nella omonima piazza di Villa Badessa di Rosciano |
GIORGIO CASTRIOTA SKANDERBEG
di Antonio Mezzanotte
Si dice e si racconta che un giorno infuriava una feroce battaglia tra l'esercito cristiano e quello turco (più numeroso) e che i combattimenti si protrassero ben oltre il tramonto. Fu allora che il comandante dei cristiani mise in atto lo stratagemma che lo avrebbe portato a una strepitosa vittoria: fece radunare un grosso gregge di capre, ordinando di legare due torce accese sulle corna degli animali per farli sembrare uomini che si muovevano nella notte e spronò il gregge contro i turchi; quelli, nell’oscurità, pensarono che andasse loro incontro un immenso esercito di agguerriti soldati e scapparono senza combattere!
Testimonianza di quell'episodio la vediamo tutt'oggi nelle raffigurazioni del comandante cristiano, che indossa un copricapo a forma di testa di capra.
Chi era, quindi, questo personaggio? Giorgio Castriota.
Si dice e si racconta che dopo la sconfitta del padre Giovanni, principe albanese, ad opera del sultano Murad II, Giorgio venne condotto ostaggio ad Adrianopoli, presso la corte ottomana, e costretto a convertirsi all’Islam: per tale motivo, assunse il nome di “Iskander” (che in turco vuol dire “Alessandro” - il riferimento era ad Alessandro Magno) e tale era l’abilità, la forza e la lealtà nei confronti del Sultano che questi lo nominò “Beg” (nobile, principe), da cui l'appellativo "Skanderbeg" (che possiamo tradurre in "principe Alessandro").
Riportò numerose e importanti vittorie alla guida degli eserciti ottomani, divenne così popolare che lo stesso Sultano temeva che aspirasse a prendersi il trono, ma Giorgio pensava ad altro; poco alla volta sentiva il richiamo della propria terra e, in fondo, anche la conversione forzata all’Islam non era stata mai accettata del tutto nel suo cuore.
Si dice che alla vigilia della battaglia di Nis, combattuta il 28 novembre 1443, decise infine di abbandonare il campo (determinando così la disfatta dell'esercito ottomano) e di tornare in Albania con 300 esuli, riabbracciando la fede cristiana. Conquistò in poco tempo tutte le città e le fortezze della regione già occupate dagli invasori e si pose a capo del movimento insurrezionale albanese contro i Turchi.
Da quel momento divenne il più temibile nemico degli eserciti ottomani, i quali, benché di gran lunga superiori di numero e di mezzi, si infrangevano sempre contro le schiere albanesi, che erano favorite dalla conoscenza del territorio e abilmente guidate dal Castriota, il quale, nonostante il ritorno alla fede cristiana e ancorché fosse divenuto il più strenuo nemico degli ottomani, continuò a chiamarsi e a firmarsi sempre con l’appellativo Skanderbeg (forse per ricordare ai soldati turchi che stavano combattendo contro il loro antico, amato e invincibile comandante).
Raggiunta una tregua con il Turco, si alleò con Re Ferrante d’Aragona, che aiutò a difendere la Corona di Napoli dalle rivendicazioni angioine: per tale motivo il Re lo ringraziò investendolo di numerosi feudi in terra di Puglia.
Dovette però tornare ben presto in armi a difesa della sua Albania e si spense di malaria il 17 gennaio 1468.
La nipote più giovane di Skanderbeg, Maria, andò sposa ad Alfonso Leognani, dei baroni di Civitaquana. Da essi ebbe origine il ramo Leognani Castriota, dal quale derivò, per il matrimonio del loro discendente Giambattista con Porzia Fieramosca, sorella di Ettore, eroe della Disfida di Barletta, il ramo dei Leognani Fieramosca, le cui vicende sono da rinvenire nelle storie di Civitaquana, Rosciano, Alanno, Cugnoli, Penne dal XVI al XVIII sec., mentre un altro ramo dei Castriota possedeva Città Sant'Angelo.
Quando nel 1743 giunsero le 18 famiglie albanesi che fondarono Villa Badessa di Rosciano (la più recente e settentrionale colonia arbëreshe), questi territori erano in qualche modo già legati al nome dello Skanderbeg e probabilmente le vicende dei Castriota nell'Abruzzo vestino (ancora poco note e da studiare) stanno a confermare che lo stanziamento badessano non fu affatto casuale, ma diretto e mirato all’interno di una trama di relazioni e interessi fra potentati familiari e militari d’origine albanese o a essi affini, da secoli presenti nell’Italia meridionale, il cui peso fu determinante nelle scelte di Carlo di Borbone nel favorire la nascita proprio di Villa Badessa.
(Nella foto: il busto di Giorgio Castriota Skanderbeg collocato nell'omonima piazza di Villa Badessa di Rosciano - PE, con l'epitaffio TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM (ossia: "a così gran nome nessun elogio è adeguato"), al quale, probabilmente, sarebbe opportuno dare una ripulita!