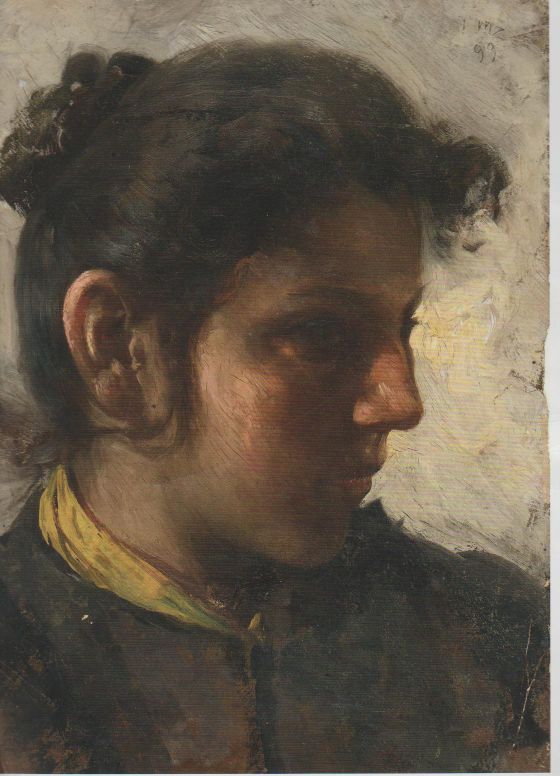Uomo di grande cultura e di multiforme ingegno, Niccola Castagna nacque il 21 ottobre 1823 a Città Sant’Angelo, ora nella provincia di Pescara, da Michelangelo, medico e patriota, e da Raffaella Della Cananea.
Trascorse la giovinezza sotto le cure affettuose e l’educazione del padre per trasferirsi poi con il fratello Pasquale ad Ortona, affidato all’insegnamento del teologo Domenico Puglisi che, nel 1848, sarà eletto Deputato al Parlamento napoletano. Conseguì la maturità classica presso il liceo dell’Aquila e da qui all’Università di Napoli dove si laureò prima in Lettere e Filosofia e più tardi in Giurisprudenza.
Ebbe tra i maestri Basilio Puoti; fu amico di Carlo Poerio, Mariano D’Ayala, Atto Vannucci, Pietro Paolo Parzanese e Niccolò Tommaseo.
Il Castagna iniziò a scrivere e pubblicare, su periodici napoletani, sin da giovanissimo, articoli, studi e saggi di letteratura; divenendo nel tempo uno scrittore elegante e garbato.
Nel 1845 rifiutava l’insegnamento al collegio “Aldino” di Prato, offertogli da Atto Vannucci, che si era recato a Napoli per il VII Congresso degli scienziati. Fu severamente richiamato dalla prefettura di polizia napoletana per aver pubblicato sulla “Sirena”, una strenna del 1846, la poesia Il gufo, dove si ravvisava un riferimento offensivo allo zar Nicola I, che l’anno precedente si era recato a Napoli
Sotto il profilo civile e politico, Niccola Castagna partecipò, insieme ad altri patrioti, a diversi convegni liberali; ciò non sfuggì all’attenzione della polizia borbonica che lo tenne costantemente sotto stretta osservazione. Nel 1847, ritenuto un pericoloso sovversivo, anche perché amico di altri “pericolosi” patrioti tra i quali Carlo Poerio e Pietro Colletta, fu arrestato con l’accusa di cospirazione ed attentato alle leggi dello Stato. Dopo la proclamazione della Costituzione nel febbraio del ’48, insieme all’amico Luigi Dragonetti prese parte alla spedizione dei volontari per la liberazione della Lombardia nel nome della libertà e della pace. Dopo i fatti di Napoli del 15 maggio 1848, fece ritorno a Città Sant’Angelo dove, spinto da molti amici, assunse l’incarico di Giudice Regio supplente, al fine di salvare la Costituzione che già cominciava fortemente a vacillare. Quando la Costituzione fu abolita e tolta ogni libertà, si rifiutò di giurare fedeltà alla monarchia borbonica e perse l’incarico. Da quel momento si ritirò al suo paese natale dove si dedicò alle ricerche linguistiche e storiche, nonché all’esercizio dell’avvocatura: i suoi studi di diritto gli consentirono di scrivere opere quali “Del metodo nella scienza del diritto” (Napoli 1847), “Storia di legislazione criminale” (ibid. 1858)e, la più nota, “Di una ragione penale” (ibid. 1864) che suscitò vasta eco soprattutto in Germania dove se ne occuparono largamente riviste specializzate.
Ripresi gli studi, approfondì le sue ricerche linguistiche e filologiche, e fornì alcune migliaia di schede a Niccolò Tommaseo che le inserì nel suo “Dizionario della lingua italiana”, facendole precedere dalla sigla “Cast.”; dal 1898 al 1900 pubblicherà su “La Rivista abruzzese” una cospicua serie di vocaboli non registrati e perciò proposti ai lessicografi. Profondo conoscitore del dialetto di Città Sant’Angelo, pubblicò “Vocaboli e modi del dialetto angolano col riscontro italiano o toscano” (Firenze 1878), e già aveva tradotto nel dialetto natale la nona novella della prima giornata del “Decamerone” di Giovanni Boccacio. Tra gli studi storici del Castagna, il più interessante è “Della sollevazione d’Abruzzo nell’anno 1814 – Memorie storiche” (Aquila 1875; II^ edizione con aggiunte, Roma 1884). Con vigore e commozione vi sono narrate le vicende dell’insurrezione antimurattiana organizzata dai carbonari di Città Sant’Angelo, Penne, Castiglione Messer Raimondo e Penna Sant’Andrea, cominciata il 27 marzo 1814 e repressa tra il 16 e il 3 aprile. Lo studio portò maggiore luce su avvenimenti sino allora poco noti o inesattamente riferiti, e fu lodato da Atto Vannucci e ampiamente utilizzato nei suoi Martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848. Isolato nella sua Città Sant’Angelo (se ne allontanò solo in occasione del congresso internazionale storico e delle tradizioni popolari svoltosi a Parigi nel 1900, al quale era stato invitato dal governo francese su proposta del corpo accademico della Sorbona), nonostante contatti epistolari con illustri letterati e le critiche favorevoli che le sue opere ottennero da Niccolò Tommaseo, Pietro Fanfani, Giuseppe Pitré, Atto Vannucci e altri, Niccola Castagna non riuscì ad inserirsi nel contesto culturale della sua epoca. Gli nocquero l’eccessivo eclettismo, e per una valutazione complessiva la dispersione di gran parte dei suoi lavori in giornali, riviste e almanacchi. Soltanto alcuni degli scritti variamente sparsi furono raccolti in volume, e tra questi si ricordano “I proverbi italiani raccolti e illustrati” (Napoli 1866; successive ediz. 1868, 1869) (“I proverbi dell’Ariosto tratti dal poema e illustrati“, Ferrara, 1877 [N.d.R.]) e “Il montanaro del Gran Sasso d’Italia” (Atri 1887), cantilene abruzzesi già pubblicate su strenne e periodici napoletani fra il 1842 e il 1846. Della sua conoscenza dei fatti del Regno delle Due Sicilie nella prima metà del secolo XIX sono testimonianza le numerose osservazioni inviate a Cesare Cantù, che gliele sollecitava, e il breve saggio “I deputati al Parlamento napoletano del 1820 e 1821” (in Rivista abruzzese di scienze, lett. e arti, XVII 1902).
Morì nella sua casa di Città Sant’Angelo il 2 marzo del 1905.