
di Angelo Iocco
La cittadina di Orsogna
è da considerarsi tra i paesi abruzzesi, dove la vocalità e la tradizione della
canzone abruzzese si conserva con freschezza e rispetto della tradizione.
Centro devoto a Maria, per la presenza della tradizionale Sagra dei Talami, che
affonda le radici a quei riti propiziatori popolari, e alle rappresentazioni
Sacre bibliche del XVI secolo introdotte dai Padri Paolotti nella distrutta
chiesa della Madonna del Rifugio, Orsogna sin dai primi saggi studiosi del
canto e delle tradizioni abruzzesi, apparsi nel secondo Ottocento, è stata al
centro dell’attenzione, risaltando per i suoi abiti tradizionali variopinti,
per i magnifici gioielli, per le “sciacquajje d’ore” (gli orecchini pendenti),
e specialmente per il canto.
Questi canti costituiscono il repertorio della Corale “La figlia di Jorio” di Orsogna, la prima corale folkloristica abruzzese a essere ufficialmente nata all’alba delle Maggiolate abruzzesi di Ortona. La sua storia è stata tracciata da Plinio Silverii (1926-2002) nel suo volumetto Orsogna in costume, tip. Brandolini 1981. Il Coro nasce nel ’20, precedentemente si pensava fosse nato nel 1929 insieme alla Corale di Poggiofiorito, tanto che ci fu anche un’importante manifestazione al teatro comunale nel 1979 per festeggiare i 50 anni. Pare che la prima esibizione fu in una festa paesana di S. Antonio di Padova a contrada La Roma di Casoli, poi immediatamente la Corale prese il volo per le manifestazioni, alla Settimana abruzzese di Pescara del 1923, a Firenze nel 1930, nello stesso anno a Roma al Quirinale insieme a un Talamo realizzato per le nozze del Principe Umberto II, a Napoli in piazza Plebiscito, al Museo Belliniano di Catania, alla Rassegna dei Cori di Roma a piazza Siena nel 1938 per la visita di Hitler, al Vittoriale di Gardone Riviera nel 1950. Nella commemorazione del 1979 vi tenne al teatro un convegno con i proff. Ernesto Giammarco, Benito Lanci, Giuseppino Mincione, Franco Potenza, Padre Donato (Giuseppe) Di Pasquale OFM, successivamente si rappresenta una commedia di Plinio Silverii, e infine il canto orsognese Bbone Ursogne.
Attilio
Bartoletti maestro del Coro orsognese
Attilio Bartoletti
nacque a Orsogna il 31 ottobre 1896 e morì a Milano il 24 luglio 1945. Primo
Maestro del Coro ENAL di Orsogna, ma non solo, grazie alla partecipazione della
storica Banda e dei gruppi corali delle Confraternite del Suffragio e della
Madonna del Rifugio, riuscì a mettere insieme un organico, fondendo le varie
vocalità sacre e profane, dirigendo anche le processioni del Venerdì santo.
Grazie a questo organico proveniente da diversi ambienti musicali, Bartoletti
mise insieme il gruppo Corale, capace di eseguire anche brani dell’opera
lirica, come Si ridesti il Leon di Castiglia, dalla Norma di Vincenzo Bellini,
insieme alle canzonette popolari. Diverse esecuzioni si tennero nel teatro
comunale. Dopo il “battesimo” a Casoli nel 1920, il debutto orsognese ci fu in
occasione dell’erigendo Parco delle Rimembranze nel 1923, dopo aver sfilato in
estate anche alla Settimana abruzzese a Pescara. Nel 1928 il Coro venne
riformato sotto l’egida dell’OND fascista, la direzione passa al Maestro Gino
Di Nizio di Pretoro, che diresse la famosa Banda. Nel 1929 Orsogna è A Roma per
rappresentare l’Abruzzo, e ottenne il secondo premio con medaglia d’oro. Nel
1930 il Coro passa sotto la direzione di Gaetano Silverii (1897-1967), di cui
ci occuperemo più avanti.
Attilio Bartoletti è
tra i primi autori orsognesi di canzoni originali, a lui seguiranno il Silverii
con Giulio Sigismondi, Plinio Silverii e Francesco Paolo Martinicchio, e anche
un certo G. Misano, oltre a Domenico Ceccarossi che musicò la canzone Lu campanile nove di lu paese me’, su
testo di Eligio Cuccionitti (celebre poeta delle Maggiolate ortonesi), per la
maggiolata di Sant’Apollinare chietino. La canzone fu poi “adottata” dal coro
orsgonese con l’elaborazione del M° Franco Potenza. Il Bartoletti scrisse
questa bella canzonetta amorosa, sull’egida delle celebri canzoni d’amore del
duo Cesare de Titta-Antonio Di Jorio (Caruline,
Vuccuccia d’oro, La canzone de l’amore, Amore me’), essa ha per titolo Marì, datata 1923. È una semplice
romanza in cui il cantore elogia le qualità fisiche della fanciulla, il nome
semplice è bello, schietto come la “vuccuccia-‘rrise”; il poeta la prega di non
rifiutare i suoi corteggiamenti, anche perché p ancora giovane “vint’anne, che
pazzije”. Nella terza strofe si denunciano alcuni elementi “colti” del poeta,
che un po’ stridono con il tema di una classica canzone abruzzese, e più che
altro fanno eco alla contemporaneità e al sentimento di giubilo che si
percepiva in Abruzzo per la Settimana abruzzese a Pescara (infatti in
quell’occasione fu presentata), ossia quando il Duce venne in città per
annunciare la fusione della città con Castellammare Adriatico e la creazione
della quarta provincia abruzzese (“Scrivesse pi’ vvantarle n’anne ‘ntìre / Si
ffusse nu D’Annunzie o n’Alighjre”).
Pubblichiamo copia
della canzonetta edita a Firenze, dall’archivio “Tommaso Coccione” di
Poggiofiorito.
Attilio Bartoletti fu
attento anche alle canzoni popolari religiose. P. Donatangelo Lupinetti ne Il Canto popolare abruzzese di genere sacro : relazione svolta al
Convegno Nazionale delle tradizioni popolari, Pescara, 23 agosto 1968
– Pescara, Centro Studi Abruzzesi, 1973, ricorda che Bartoletti trascrisse il
celebre Canto delle Dodici Stelle che si esegue in Abruzzo nel mese mariano, ma
anche nelle Novene dell’Assunzione, ad esempio tra Castelfrentano e
Casacanditella:
Le stelle sono una, la
Madonna è bella,
le stelle sono una, la
Madonna è bella.
Che sole, che luna, che
gioia d’amor!
Che sole, che luna, che
gioia d’amor! (ecc., fino al numero 12)[2].
Bartoletti morì a
Milano, dove si era trasferito per lavoro, stroncato dopo aver assistito ai
tragici bombardamenti alleati della città, a qualche mese dalla liberazione nel
1945.
Gaetano Silverii e Giulio Sigismondi
 |
Giulio Sigismondi |
Virgilio Sigismondi,
figlio del poeta Giulio (1893-1966), racconta che in quegli anni il padre era
in diversi paesi attorno Lanciano, svolgendo il ruolo di consigliere comunale e
altri affari amministrativi. A Rocca San Giovanni ad esempio, frequentò il
musicista Arturo Colizzi con cui scrisse diversi pezzi celebri, come Chi t’ha ditte e Senza mamma. A Orsogna Sigismondi conobbe il Silverii, di cui
restano due canzoni scritte per la corale: La
tresche e Lu fazzole. Sono due
canzoni scritte tipicamente per delle scenette agresti rappresentate dalla
Corale. La prima racconta il momento della trescatura del grano, e il grande
concorso e affannarsi dei contadini per attaccare il giogo ei buoi e arare il
campo. Sigismondi si conferma, con le secche note del Silverii, maestro
dell’onomatopea, nel rappresentare il suono e il gesto dei trescatori:
“Zza-zza-zza!
Li fa’ vulà,
vole li listre, vole le
sgrèjje,
pe’ guidà, Cicche è lu
mejje!”
La seconda canzone è
una canzonetta d’amore, il poeta invita la fanciulla stizzosa a non tenergli il
broncio, altrimenti le farà un dispetto, le strappa il fazzoletto che ha sulla
testa, e le lascerà i capelli scoperti al vento (ricordiamo che all’epoca avere
i capelli sciolti era sintomo di sconvenienza e facili costumi), e gioca
soprattutto nelle strofe seguenti, ad alludere alla faccia che farà sua madre,
se la vedrà…scoperta!
La
Corale di Orsogna e i suoi canti
Sotto la direzione di
Silverii, il Coro di Orsogna nel 1931 è a Trieste in Piazza Unità d’Italia,
dove si esibisce con canti e danze (la famosa Cotta e il Saltarello), e la
turné prosegue per Firenze, Bolzano, di nuovo a Roma nel 1939 alla Rassegna dei
cori, sotto la direzione del fisarmonicista Tommaso Coccione di Poggiofiorito.
Silverii fu a direzione del Coro anche dopo la “tempesta bellica” che ridusse
Orsogna in macerie, grazie a un fortunato ritrovamento dell’armonium di casa
sua, poté lentamente rimettere in piedi l’organico, il 20 giugno 1949 il Corto
torna a cantare al teatro comunale, alternando brani folkloristici a quelli
classici del Nabucco di Verdi, all’Iris di Mascagni, la Vergine degli Angeli e La
forza del destino. Da qui in poi prese il nome di Coro ENAL. Riprendono le
turné in Catania, Pescara, Teramo, Agrigento, nel 1953 al Raduno dei cori
folkloristici di Roseto degli Abruzzi, venendo premiato dalla giuria composta
dai maestri della canzone abruzzese Luigi Illuminati, Guido Albanese, Antonio
Di Jorio, Olindo Jannucci, Erminio Sallustio; a seguire il Coro si sposta in
Emilia Romagna a Reggio, eseguendo l’abile ballo delle conche, poi nel 1965 a
Roma, Milano, nel 1966 a Bonn, Bruzelles, Waterloo. Nel 1969 ottenne il primo
premio del Concorso “Paranza d’oro” a Pescara. Dal 1967 il Coro passa, fino al
2025, sotto la direzione dell’Avv. Mario Tenaglia, che promuove diverse
incisioni in audiocassette e vinili, e poi cd, quest’ultimo sotto la direzione
del romano M° Franco Potenza, che armonizza, forse in maniera troppo da
Cappella polifonica, le canzoni orsognesi, conferendo una natura “ibrida e poco
abruzzese” alle antiche canzoni. Sotto la direzione di Tenaglia, il Coro
prosegue le turné, nel 1977 a Caltanissetta ottiene il premio Tritone d’oro con
la canzone d’autore Addije, muntagne
del M° Potenza, un canto a lamento, tristissima, che ricorda il Lamento della vedova di Scanno,
ascoltandolo non si può aver davanti agli occhi la scena degli emigranti che
sono costretti ad abbandonare i propri paeselli sulle rocche per trovare
lavoro, oppure il quadro di Teofilo Patini delle Bestie da soma, con quegli occhi scavati dalla fatica e dal lavoro.
I successi continuano a
New York (25-30 agosto 1981), il 31 agosto a Boston. In questi anni assume il
nome definitivo “La figlia di Jorio”, in omaggio al quadro del pittore
Michetti, ispirato alla modella Giuditta Saraceni di Orsogna e agli ampi
panorami che si godono della Majella dal belvedere paesano. In concomitanza con
il Coro di Orsogna, si sviluppò un altro Coro in America, dal nome “Paese mio”,
che ugualmente riproponeva brani orsognesi.
Il repertorio della
Corale, oltre ai canti classici che presentiamo, anonimi, cioè popolari, si
alternano quelli d’autore, composti per le Maggiolate. Tra questi figurano Mare turchine di Antonio Ambrosini e
Attilio Fuggetta, Serenata spassosa
di Evandro Marcolongo e Antonio Di Jorio, Lucenacappelle
di Giulio Sigismondi e Giuseppe Gargarella, la Ninna nanne di Cesare de Titta e Camillo de Nardis, bellissima e
dolcissima, Addije muntagne di Franco
Potenza, La tresche di
Sigismondi-Silverii, Lu fazzole
(degli stessi), Lu pinate de le fojje
di Cesare de Titta e Guido Albanese, concludendo sempre il tutto con l’aria Bbone Ursogne.
Riportiamo alcune
fotografie estratte da ritagli di giornale conservati da Vittorio Pace,
gentilmente messi a disposizione.
Testi
dei Canti popolari di Orsogna
AMORE, AMORE, ACCIUCCHEME SSA RAME
Modo orsognese
I
Amore, amore,
acciuccheme ssa rame.
Amore, amore,
acciuccheme ssa rame.
RIT
Fammile coje, fammile
coje,
fammile coje, a mmè stu
bbelle fiore!
Ripetuto due volte
II
Quante ne fa’ na mamme
pe’ la fijje!
Quante ne fa’ na mamme
pe’ la fijje!
RIT
Po’ ve’ lu spose, po’
ve lu spose,
e po’ ve’ lu spose, e
ze la porte vie.
Ripetuto due volte
III
Piagne la mamma ca la
fijje spose,
piagne la mamma ca la
fijje spose…
RIT
Mo’ se ne va, mo’ se ne
va,
e mo’ se ne va la fate
de la case!
Ripetuto due volte
ARIA MARINE, ARIA DI MUNTAGNE,
ovvero BBONE URSOGNE!
Canzone
popolare abruzzese di Orsogna, il cui motivo è usato anche dal M° Mario
Santucci col Coro di Tornimparte, per il canto “Amore amore acciuccheme ssa
rame”, al posto della versione più popolare raccolta da Ettore Montanaro, e
riarmonizzata dal M° Giuseppe Di Pasquale
I
Aria
marine, aria di muntagne!
Aria
marine, e aria di muntagne!
Bbone
Ursogne! E bbone Ursogne,
e
bbone Ursogne, e chi ti vo’ landà!
II
Ursogne
mo’, ‘nzi chiame cchiù Ursogne!
Ursogne
mo’ ‘nzi chiame cchiù Ursogne…
Ze
chiame lu… e ze chiame lu…
E
ze chiame lu…Paese de l’Amore!
Ripetuto un’altra volta.
Spartito dell’inno orsognese, dall’Archivio “Tommaso Coccione” Poggiofiorito
Di questa canzone esiste l’armonizzazione fatta dal M° Potenza della sola prima strofe, in dialetto, ripetuta due volte, per l’incisione fatta su cd.
O colle, vicine a la
Majelle,
vasciate da lu rise de
lu sole:
paese belle addo’ so
nnate
nchi lu pinzìre corre e
vole!
O campanile, spande la
voce de la feste
Lu cante de l’amore:
purte la ggioje pe’
ogne case:
Ndi-ndo-ndo…
O Campanile belle me’,
i t’arcorde, da luntane
penze a tte!
Inedito è questo canto:
Orsogna nostro, del M° Giuliano Misano. Il canto non è di tradizione orsognese,
e sembra di un dilettante, poiché alterna frasi dialettali locali a frasi
napoletane. Anche la forza espressiva non è granché, fu composto da come ci
pare di capire, dopo la distruzione della guerra, ed è un inno alla rinascita
sociale.
I
Orsogna lu sapimme
noi gli studiosi che
c’è state.
Lu monne l’ha ludate,
li nume li cunuscime,
è inutile che li
facimme.
II
E pe’ ffa finì sta
ludate supraffine
Nu cunsije a
l’Abruzzise:
vulìmmece bene, nen
coste na prese.
LA GIOVENTU’ DI OGGI
Popolare
orsognese
Cantato
dal Coro folk degli Emigranti “Paese mio” del M° Rocco Scenna.
Da
come dimostra una audiocassetta con il passaggio di un nastro-geloso del 1979,
il canto era popolare a Orsogna, e fu registrato da un gruppo di contadine che
cantavano “a responsorio”, con la ripresa di un verso o inizio strofe da parte
della prima cantate, e seguita immediatamente dalle compagne.
I
La
giuvintù di oggi nin ‘è cumposte,
quante
ne spenne a mette tutt’apposte!
‘Nza
use cchiù lu stare, ‘nza use ora la bursette,
pecché
lu stare, je sfasce ji bucculette!
RIT
Mo’
‘nin za use cchiù a spusà,
pì
nin vedè, la robba spricà!
Questa
è la vera sincerità:
che
li quatrine non ci ni stà!
II
E
tutte le dumeneche a mattine,
je
nen ne vojje sapè de la cucine!
La
Messe ggià ‘ccennate: esse ‘nzà priparate!
J’avaste
a mette la ciprie prufumate!
RIT
E
quanne jesce p’jì a la Messe,
li
giuvinutte ji ‘uard’ appresse!
Ji
‘uarde appresse une pì d’une:
quest’è
la vera fregature!
III
Tutte
li giuvedìì va’ a lu Mercate,
appena
ci va la matre z’arbunate.
Ci
sta li piste spicce, ma esse nin z’assette,
finché
lu prime che passe je schiaffe lu pette
Zi
mette lu russette, zi fa li bucculette:
zi
fa na riggiustate a lu riccitelle!
RIT
Mo’
nin z’ause cchiù a spusà, ecc.
MO
VE’, MO VA’
Versione
orsognese
Il
canto nella pria parte riprende lo stornello elaborato da Ettore Montanaro come
“A la Francavillese”, meglio noto come “Maria Nicole” tra le varie corali; la
seconda parte invece riprende lo stornello classico abruzzese del chietino noto
come “Mo’ ve’, mo ve’, mo’ va’”.
I
Ti
zi fatte la vesta rosce, che da luntane z’arichenosce,
pover’a
tte, Mariuccia mè, Mariuccia mè!
Ripetuto
due volte
E
chi te l’ha fatte fa’, ive na bella giuvinette’,
ti
purive marità!
Ripetuto
due volte
RIT
E
la jerve di l’ulive, pe’ sott’ a terre va’.
se
‘n ti vò cchiù Niculì, munachella ti dajje da fa!
Mo
ve’, mo ve’, mo ve’, mo va’….
Tu
vittine piane piane, nin mi ti fa chiamà!
Ripetuto
due volte
II
Ti
zi fatte bille scarpette, tacchi àvt e punta strette.
Puvr’
a ttè, Mariuccia me!
Ti
zi fatte lu ricce bionde, nghe nu pettn sopr’ a la fronte,
puvr’
a ttè, Mariuccia me!
E
chi te l’ha fatte fa’, ive na bella giuvinette ecc.
RIT
E
la jerve di l’ulive, pe’ sott’ a terre va’, ecc.
SOPRA STU CORE
popolare
Dal
disco FOLKLORE ABRUZZESE, del Coro degli Emigranti di Orsogna “Paese mio”
direttore M° Rocco Scenna
I
DONNE:
Quanta luce, quante stelle!
UOMINI: Quante lucenacappelle!
DONNE:
Chi sa dove, chi s’artrove a nnu, a nnu!
UOMINI:
E nu’ pure c’artruvème!
C’artruvème,
c’artruvème, c’i spignème!
Sole,
sole, ‘nzi po’ stà!
Cara
notte, scure, scure,
fa
paure a camminà!
RITORNELLO
DONNE:
Ma vu’ spittì, Carmè!
Ci
sta na lucia ttè!
UOMINI:
Ci sta na lucia ttè!
DONNE:
Che da la lumìne fa’ a fra sti capille te!
UOMINI:
Fra sti capille te!
TUTTI:
Vacimici, Carmè, addurmiti, Carmè!
Sopra
a stu core, statt’ accuscì!
II
DONNE:
Quanta fiure, quante fiure!
UOMINI:
Che si sente tra lu ‘scure.
DONNE:
A mijjare, a mijjare addurà!
UOMINI:
E na luce da luntane
Va girenne piane-piane.
TUTTI
Sajje
e cale, saje e cale a ccore te!
Na
carezze, du spusine,
e
mo’ sajje, e ze va’ ddurmì.
RITORNELLO
DONNE:
Ma vu’ spittì, Carmè!
Ci
sta na lucia ttè!
UOMINI:
Ci sta na lucia ttè!
DONNE:
Che da la lumìne fa’ a fra sti capille te!
UOMINI:
Fra sti capille te!
TUTTI:
Vacimici, Carmè, addurmiti, Carmè!
Sopra
a stu core, statt’ accuscì!
TI LI SO’ DITTE, MARIUCCE
Popolare
orsognese. Nel ritornello ci sono diversi elementi in comune, rielaborati, con
il canto abruzzese All’orte.
I
Ti
li so’ ditte, Mariucce ‘nci andà,
manche
a la fonte, manche a la fonte!
Ti
li so’ ditte, Mariucce ‘nci andà,
mache
la fonte l’acqua a pijà!
Si
tu ci vi’, mi fì nu piacere,
n’atre
me pijje, n’atre me pijje.
Se
tu ci vi’, mi fì nu piacere,
n’atre
mi pijje cchiù bbelle di te.
RIT
Cinque,
la pari sei, la sette ‘llallà!
Piagne
Rusine, piagne Ruisine!
Cinque,
la pari sei, la sette llallà!
Piagne
Rusine, all’Americhe si va!
II
Jamm,
Tittina mia, a lu vallone,
jamme
Tittina mia, a lu vallone.
Ti
facce fa’ li panne senza sapone!
Nachetazzera-zzera-zzera…
Nachetazzera-zzera-zzà!
III
Jamme
, Tittina mia a la stazzione,
jamme
Tittina mia a la stazzione.
Jame
a pijà lu trene, ce ne jeme a nozze!
Nacheta-zzera-zzera-zzà!
Ripetuto due volte.
[1] Cfr. Vincenzo
Melocchi vita opere e miracoli del commendatore, scritto da Gerardo Di Cola ed edito
dalla éDICOLA editrice di Castellana, 2023
[3] Notizie estratte dalla biografia nel volume a cura di Virgilio Sigismondi Canzuna nustre – Canti popolari abruzzesi di Giulio Sigismondi, Lanciano 1991.





























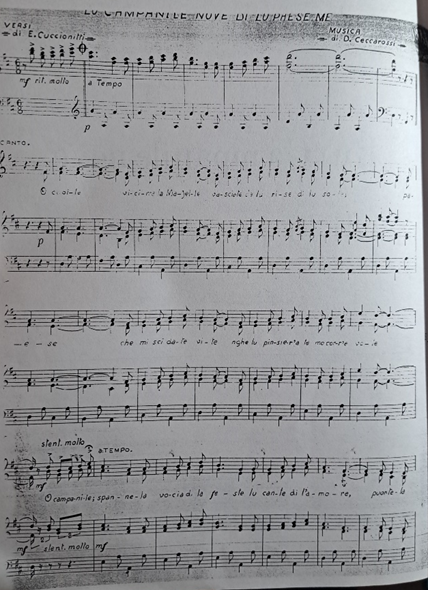






Nessun commento:
Posta un commento